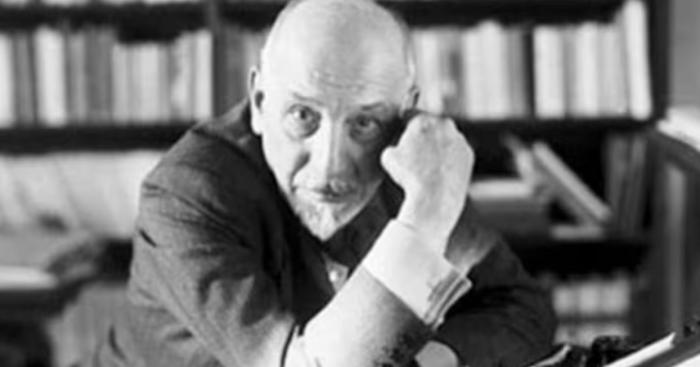Nel romanzo Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello offre una riflessione profonda e complessa sulla giustizia, l’identità e la libertà, intrecciando questi temi con la tragedia dell’individuo moderno. La storia si sviluppa attorno a Mattia Pascal, un uomo che, creduto morto dalla società, ha la possibilità di ricostruire completamente la propria vita e identità, assumendo il nome di Adriano Meis. Questa possibilità, che inizialmente appare come un’opportunità di libertà assoluta, si rivela ben presto un’illusione, mettendo in luce il conflitto tra l’individuo e le strutture sociali e giuridiche che regolano la vita collettiva.
Pirandello, attraverso la figura di Mattia, affronta la questione dell’identità e della giustizia non solo come concetti astratti ma come costruzioni sociali. L’individuo, pur avendo la possibilità di sfuggire alle convenzioni imposte dalla società, non può esistere al di fuori del sistema giuridico e delle normative che lo riconoscono come parte di una comunità. La nuova identità di Adriano Meis, pur concedendo una libertà formale, lo priva dei diritti e dei legami sociali che sono fondamentali per vivere pienamente, come dimostrato dalla sua impossibilità di agire giuridicamente. Non può denunciare un furto, sposarsi o rivendicare un torto subito, poiché non è riconosciuto ufficialmente dalla legge.
Questa situazione solleva un interrogativo fondamentale: è possibile svincolarsi completamente dalla propria identità senza entrare in un vuoto giuridico e sociale? La risposta che il romanzo suggerisce è negativa. Pur avendo una nuova identità, Adriano Meis non può esistere pienamente come individuo nella società, poiché la giustizia tutela solo chi è riconosciuto ufficialmente come parte della collettività. Pirandello, con questa narrazione, mette in discussione la rigidità delle strutture sociali, sollevando una riflessione sulla natura della giustizia stessa e sul suo rapporto con l’individuo.
Il problema dell’identità giuridica si lega alla teoria del contratto sociale di Jean-Jacques Rousseau, che nel Contratto sociale (1762) affermava che l’individuo, entrando a far parte di una società organizzata, accetta implicitamente le leggi e le regole che garantiscono la convivenza collettiva. Mattia Pascal, nel momento in cui simula la propria morte e si allontana dal sistema, diventa un’anomalia giuridica, priva di diritti e di protezione. Non essendo più vincolato ai doveri civici, perde anche la possibilità di esercitare i diritti che derivano dall’appartenenza a una società. In tal senso, il suo tentativo di sfuggire alla propria identità diventa una condanna, poiché senza il riconoscimento sociale, l’individuo si trova escluso dal consorzio umano, privo di qualsiasi protezione giuridica.
Pirandello non si limita a raccontare la storia di un uomo che cerca di reinventarsi, ma attraverso il dramma di Mattia-Adriano offre una critica al sistema giuridico e sociale che regola la vita umana. L’identità, anziché essere un fatto puramente soggettivo, si rivela una costruzione imposta dall’esterno, regolata dalle leggi, dai documenti e dai riconoscimenti ufficiali. L’incapacità di sfuggire completamente a queste strutture sociali porta Mattia a una condizione di esclusione totale: il protagonista, credendosi libero, scopre di essere privo di un’esistenza concreta e riconosciuta.
Il ritorno alla sua vecchia identità segna il fallimento del tentativo di riappropriarsi della propria vita precedente, ormai svuotata di senso. La conclusione della vicenda, con Mattia che torna a essere “il fu Mattia Pascal,” evidenzia l’impossibilità di una libertà assoluta all’interno di una società che impone regole rigide e che non ammette l’esistenza al di fuori di queste. La giustizia, dunque, appare come una costruzione sociale che definisce chi ha il diritto di essere riconosciuto come individuo e chi, invece, è destinato a rimanere escluso, un tema che Pirandello esplora con grande intensità.
La giustizia come costruzione sociale
Pirandello ci invita a riflettere sulla giustizia non solo come un principio teorico o astratto, ma come una costruzione sociale vincolata alle strutture normative e ai meccanismi istituzionali. La giustizia, infatti, non esiste in senso assoluto, ma si manifesta attraverso un sistema di leggi che regolano la convivenza collettiva. Il caso di Mattia Pascal, divenuto Adriano Meis, mostra come questo sistema si dimostri inadeguato nel rispondere alle esigenze individuali. Adriano, al di fuori del sistema giuridico, non è un pericolo per gli altri, né un sovversivo, ma un individuo incapace di vivere la propria esistenza pienamente, poiché privato dei diritti che derivano dal riconoscimento ufficiale della sua identità.
Questa problematica si lega anche alla riflessione filosofica di Thomas Hobbes, che nel Leviatano descrive la legge come un meccanismo necessario per evitare il caos della condizione naturale. Tuttavia, nel caso di Mattia, vediamo un ribaltamento di questa logica: l’esclusione dal sistema giuridico non porta al caos, ma a una vita priva di diritti, senza possibilità di reclamare giustizia. Pirandello, quindi, mostra l’inadeguatezza del sistema giuridico nel rispondere alle contraddizioni e alle complessità della vita individuale.
Anche la riflessione di Immanuel Kant sulla giustizia come ideale regolativo diventa centrale per comprendere il messaggio del romanzo. Kant considera la giustizia un principio che orienta l’agire umano, ma che nella sua applicazione pratica risulta sempre imperfetto e parziale. La giustizia, secondo Pirandello, non è mai un valore universale, ma un sistema che risponde alle necessità storiche e contingenti di una società, il che la rende inadatta a risolvere le sfide esistenziali dell’individuo.
La giustizia e il senso del tragico
Il tragico in Pirandello emerge dalla contraddizione insanabile tra l’aspirazione dell’individuo alla libertà e le regole imposte dalla società. In Il fu Mattia Pascal, questa tensione diventa centrale nella vicenda del protagonista, il quale, pur ottenendo la possibilità di reinventarsi, scopre che la libertà assoluta è un’illusione. Senza un riconoscimento giuridico e sociale, l’individuo non può dare un senso pieno alla propria esistenza.
Questa opposizione tra l’individuo e le strutture sociali richiama la concezione di giustizia elaborata da Friedrich Nietzsche ne La nascita della tragedia, in cui la realtà è vista come il risultato di una tensione tra due principi contrastanti: l’apollineo, simbolo dell’ordine e delle leggi, e il dionisiaco, che rappresenta la libertà e il caos. Mattia Pascal, nel tentativo di sfuggire alla propria identità e di costruirne una nuova, incarna la tentazione di liberarsi dai vincoli sociali. Tuttavia, la società in cui tenta di inserirsi è governata da leggi che non ammettono la possibilità di un individuo senza identità giuridica, e la sua esperienza diventa una dimostrazione del fallimento di una sintesi tra ordine e libertà.
L’epilogo del romanzo, con il ritorno di Mattia alla sua vecchia identità, segna il fallimento del tentativo di superare le strutture imposte dalla giustizia sociale e giuridica. Mattia diventa un fantasma sociale, sospeso tra l’esistenza e l’inesistenza, incapace di riappropriarsi della propria vita precedente. Questo esito tragico mette in evidenza l’irriducibile distanza tra la giustizia formale e le esigenze individuali, mostrando come il sistema normativo, anziché garantire la realizzazione personale, possa trasformarsi in una gabbia che soffoca ogni aspirazione autentica.
Conclusione
Il fu Mattia Pascal è un romanzo che pone al centro una riflessione complessa su giustizia, identità e libertà. Pirandello decostruisce le certezze sulle quali si fondano le strutture sociali e giuridiche, mostrando come esse siano incapaci di rispondere alle contraddizioni dell’esistenza umana. La vicenda di Mattia Pascal diventa una parabola sul conflitto tra l’individuo e la società, sull’impossibilità di sfuggire completamente alle convenzioni sociali senza incorrere in conseguenze irreparabili. La giustizia, lungi dall’essere un valore universale, si rivela come una convenzione sociale che, pur cercando di mantenere l’ordine, finisce spesso per escludere l’individuo. Pirandello ci ricorda che la giustizia non è mai assoluta, ma un fragile compromesso tra le esigenze collettive e i desideri individuali.